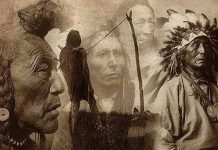Milano 25 Aprile 2021
Sparta contro Atene: la prima governata da un sistema autoritario, oligarchico e soldatesco, la seconda “culla” del pensiero libero e della democrazia. Così ci insegnano a scuola, da sempre. Ma la Storia, scavandola, riserva sorprese ed Eva Cantarella prova a smitizzare lo schema.
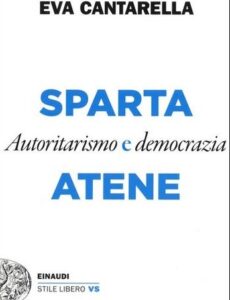
Ed è la donna soprattutto, con la sua posizione sociale, a smontare il quadro tradizionale, quasi rovesciandolo: molto più libera e intraprendente nella militarizzata capitale della Laconia (l’area sud-orientale del Peloponneso) che non sotto il “democratico” Partenone. Con Sparta-Atene, Autoritarismo e Democrazia (Einaudi), l’autrice – ha insegnato Diritto romano e Diritto greco antico alla Statale di Milano – fa pulizia di tanti luoghi comuni: le due città per quanto diverse non sono certamente opposte e incompatibili, ma rispondono ad un Dna comune: la civiltà greca. Che interessi economici e politici, e ambizioni, le abbiano rese acerrime nemiche, in pace e in guerra, non esclude archetipi analoghi.
Hanno lo stesso statuto di polis, sono città-stato. La stessa divinità protettrice, Atena. Il culto degli eroi fondatori (Licurgo a Sparta, Teseo ad Atene) e dei morti in guerra. In entrambi i casi una primitiva monarchia ha ceduto il potere al consiglio degli anziani: l’Areopago ad Atene e la Gerousia a Sparta. Da nessuna parte le classi privilegiate si devono sporcare le mani con il lavoro e possono dedicarsi al più nobile “mestiere di cittadini”.

È vero, in Atene il potere doveva fare i conti con l’assemblea popolare e grazie al sorteggio delle magistrature e ai relativi stipendi, anche i meno agiati potevano accedere ai massimi incarichi: i primi passi verso la democrazia, come la intendiamo oggi. Ma ci sono tanti “ma” e il famoso elogio di Pericle alla diversità di Atene celebra forse più sogni che la realtà di fatto. I diritti erano riservati ai liberi cittadini maschi, anche meno di un sesto su circa 300mila abitanti; e fu proprio Pericle a ridurli a chi avesse genitori entrambi ateniesi, scoraggiando matrimoni con “extracomunitari”. I meteci, quelli venuti da fuori, ne erano esclusi. Nemmeno un Aristotele di Stagira aveva diritto di voto.

Pur con tutti i contrappesi democratici, anche qui dominavano poche famiglie responsabili di una politica imperialistica ante litteram, ignota a Sparta: guerre espansionistiche, severo controllo politico con pesanti tributi sulla vasta area di influenza. Una volontà di dominio all’origine – lo ammette l’ateniese Tucidide – dei disastrosi conflitti con Sparta e Siracusa e del declino della polis.
E Sparta, la città-caserma della Laconia? Anche qui una formale parità di diritti solo tra i cittadini a pieno titolo, gli Spartiati e condizioni dure per gli Iloti, in fondo alla scala sociale, praticamente schiavi. Meno gravosa la supremazia sui Perieci, gli abitanti delle città alleate, esenti da servitù economiche e autorizzati a partecipare alle Olimpiadi, il Gotha della grecità. Sparta inoltre ha goduto in Atene di sostenitori intellettuali del calibro di Platone che, deluso dalla democrazia macchiatasi della condanna a morte di Socrate, nella Repubblica prefigura una città ideale con diversi tratti della capitale della Laconia. Di spartano doc, nota Cantarella, c’era l’educazione comunitaria, tipica di uno stato autoritario: si nasceva per diventare cittadini-soldati e chi pareva troppo fragile era subito esposto sul Taigeto. Già a sette anni il maschio veniva tolto dalla famiglia e inquadrato in organizzazioni militaresche.

Gli anziani vigilavano occhiuti sulla crescita del giovane sottoposto a estenuanti esercizi fisici, prove-limite di resistenza, austeri costumi, cene frugali (il brodetto nero). E prima di affrontare l’altro sesso, i ragazzi dovevano superare un apprendistato con gli amanti-precettori (anche in Atene la pederastia rientrava nella formazione, ma non così istituzionalizzata). Più avanti in età era, però, quasi un obbligo sposarsi per mettere al mondo futuri soldati. Dai trenta ai sessanta servizio militare permanente. Ma c’è il risvolto della medaglia: con il maschio stabile sotto le armi, toccavano alle donne molti impegni sociali. Così le spartane non venivano discriminate e chiuse in casa come le giovani ateniesi, il cui futuro era sposarsi e fare i lavori domestici. Avevano possibilità di istruirsi – ad Atene questo magari era privilegio delle escort dei potenti, tipo Aspasia – e talvolta di ereditare i beni paterni.

Gloria alla madre se il figlio cadeva in guerra. Come gli uomini, nude o in abiti succinti praticavano sport non sempre da signorine – disco, giavellotto, corsa, lotta – e potevano concedersi una gestione disinvolta anche del privato. Non tutte rose e fiori, comunque: i mariti potevano sempre venderle. Due città dunque assai meno diverse di quanto si dice. Nel libro si delinea come si sia, invece, stratificata l’ immagine dei due modelli opposti già a partire dal Rinascimento, ricordando le aspre divisioni tra i padri dell’Illuminismo: Rousseau esaltava la virtù di Sparta, Voltaire la irrideva, affascinato dalla splendida cultura ateniese. In piena rivoluzione francese, sotto il Terrore, Sparta era tornata a essere un esempio influenzando, a seguire, un filone giacobino sempre presente in Occidente. Per gli uomini di cultura dell’Ottocento, Grecia voleva dire Atene; nel secolo scorso il Nazismo ha visto nello spartano l’anticipazione del suo “uomo nuovo”. Anche la guerra fredda ha contribuito alla polarizzazione, Usa /Atene, URSS/Sparta, e perfino in era Trump la divisione è sopravvissuta, come quella tra Stati Uniti e Cina. Lo stesso tycoon Usa aveva dichiarato: I love the Greeks ( ammesso, maligna la Cantarella, che ne sapesse il significato).
La conclusione è che da 2500 anni i due modelli, utilizzati da destra e sinistra, da conservatori e rivoluzionari, hanno alimentato uno spregiudicato gioco delle parti. Ma il ruolo femminile può far saltare tanti pregiudizi. Friedrich Hegel, il grande filosofo tedesco, non aveva definito la donna “eterna ironia della comunità”?
Immagine di apertura: l’elmo spartano (foto di Billy A)