Milano 25 Aprile 2021
Alla fine di gennaio del 2020 il Consiglio dei Ministri dichiara “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario”. Poco dopo, il 23 febbraio viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che introduce in Italia un’innovazione epocale: al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene riconosciuto il potere di emanare i Decreti del Presidente del Consiglio, i tanto discussi DPCM.

Con questo nuovo strumento a partire dal primo marzo, quando viene istituita la Zona Rossa (dieci comuni in Lombardia e Vo’ in Veneto), e successivamente con il lockdown, si arriverà a sospendere diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (mai era successo prima). Proviamo ad elencarli: la libertà personale (articolo 13 della Costituzione), la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione (articolo 17) la libertà di insegnamento (articolo 33), il diritto all’istruzione (articolo 34), la libertà di impresa (articolo 41). E forse ne abbiamo dimenticato qualcuno…… Una contrazione eccezionale commisurata ad una circostanza eccezionale, l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid 19 fuori controllo.
Ci invita a riflettere su questa “necessaria deriva giuridica” un libro recentissimo, La giusta distanza (Mondadori), scritto dall’ex magistrato della Corte d’Appello di Milano Amedeo Santosuosso (attualmente insegna Diritto, Scienza e nuove tecnologie al dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Pavia) e da Sara Azzini, avvocato a Cremona. «Questi Decreti del Presidente del Consiglio non passano dal Parlamento, sono una sorta di trauma istituzionale» precisa Santosuosso. «Non c’è dubbio che la limitazione dei diritti fondamentali, la libertà di movimento ad esempio, attraverso un atto amministrativo qual è il Decreto del Presidente del Consiglio, è un’anomalia – aggiunge Sara Azzini – . Disposizioni del genere devono essere supportate da un decreto legge del governo, come è avvenuto in seguito, a partire dal novembre del 2020. Evidentemente, l’attivazione di questa scorciatoia aveva motivazioni politiche».
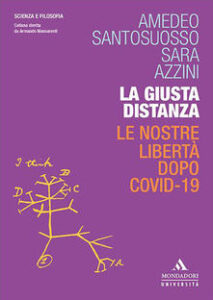
La nostra Costituzione non prevede poteri di emergenza, a differenza di quella francese, ma secondo Massimo Luciani, Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti tra il 2015 e il 2018 «la deliberazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 ha il proprio fondamento nel Codice della protezione civile, fonte primaria, la cui legittimità è già stata vagliata dalla Corte Costituzionale che ha affermato come nel ricorrere di così gravi emergenze risulta giustificato che si adottino misure eccezionali». L’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in una intervista dell’aprile 2020, quando era Presidente della Corte Costituzionale, affermava «che la nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede lo stato di eccezione. Dunque, anche in situazioni di crisi valgono i principi di sempre, ma ciò non significa che non si debba tener conto delle circostanze e della loro peculiarità… Potremmo dire che i principi costituzionali sono sempre “finestre aperte” sulla realtà». Ma c’è anche chi sostiene che un Presidente del Consiglio non può con i suoi decreti cambiare la Costituzione. «La libertà di movimento, come tutte le altre libertà non sono consentite da un “governo”; la libertà legittima il governo, non viceversa» ha osservato più volte Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

«Anche mettendo da parte i toni accesi della bagarre politica, evidentemente un problema c’è – sottolinea Santosuosso –. Soprattutto mancano strumenti di valutazione “quantitativa” della limitazione dei diritti, che consentano di individuarne il peso, la rilevanza. I diritti e le libertà, sono, di solito, esclusi dal raffronto con gli aspetti economici, occupazionali, sociali, relativi alla salute, che invece sono esprimibili in termini quantitativi (per esempio, il numero di occupati, di ricoveri, l’entità della produzione di beni e servizi)».
«D’altro canto, – prosegue l’ex magistrato – l’elaborazione di modelli di previsione che consentano di far emergere correlazioni tra regola giuridica dettata dall’emergenza e limitazione delle libertà fondamentali è di grande importanza per il legislatore che avrebbe così a disposizione strumenti per individuare un equo bilanciamento tra interventi dettati dall’emergenza e salvaguardia dei diritti».

I due autori propongono, allora, alcuni parametri per valutare il peso della limitazione dei diritti fondamentali. Ad esempio per la libertà di movimento, si potrebbe definire uno stato 1, quello senza divieto (nessuna compressione), uno stato 2, libertà di movimento solo nella propria regione (compressione lieve), uno stato 3, uscire solo per acquisti essenziali nel raggio di 200 metri (compressione grave), uno stato 4, divieto di uscire di casa (compressione totale). A questa valutazione va aggiunto il fattore tempo (ad esempio, 1 / 2 / 3 / 4 mesi o oltre) che più si prolunga, più rende onerosa la misura restrittiva. Ovvero, una compressione leggera, ma prolungata nel tempo, aggrava la limitazione delle libertà. Sono domande assolutamente necessarie in un Paese che da un anno fa i conti con una sorta di “prigionia” esistenziale.
«E non c’è dubbio – concludono Santosuosso e Azzini – che l’esercizio prolungato di superpoteri (più o meno) rende difficile distinguere fra la regola e la sua eccezione, confonde l’opinione pubblica. Ma il vero rischio è l’assuefazione. Un’emergenza non è un’interruzione neutrale; è piuttosto una condizione in cui il potere guadagna spazio e chi lo impersona guadagna potere. Ci vuole coraggio civile e responsabilità istituzionale per rompere questo cerchio. Chi lo avrà?»
Immagine di apertura: foto di Alessandra Koch





