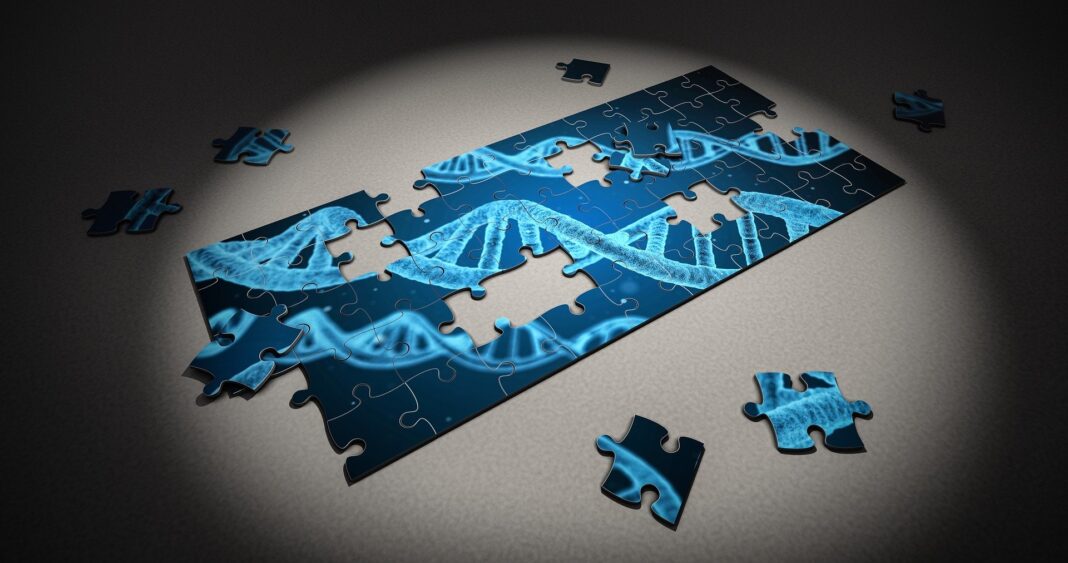I Romani discendono dagli Etruschi o dai Greci? In realtà, le ascendenze sono molteplici e sorprendenti. Il loro più recente albero genealogico, pubblicato dalla rivista americana Science, in copertina l’8 novembre scorso, ha analizzato campioni di Dna umano (la lunga elica all’interno del nucleo delle cellule sede della nostra identità genetica) proveniente da 29 siti archeologici di Roma e territori limitrofi.

Ne è emerso un quadro inaspettato, un vero e proprio “minestrone” genetico che giustifica l’espressione Roma Caput Mundi. Già nei millenni che precedettero la fondazione dell’Urbe, l’area attorno al Tevere fu incrocio di migrazioni da ogni angolo del mondo all’insegna di una diversità e di un’inclusività che caratterizzeranno poi tutta la storia della città. È quanto emerge dalla ricostruzione genetico-storica condotta da un team internazionale di genetisti, bioinformatici, antropologi, archeologi e storici della Università La Sapienza di Roma e di quelle di Stanford e di Vienna, oltre ad altre istituzioni italiane.
Tra siti archeologici, sofisticati esami di laboratorio e analisi di dati antropologici, frammento dopo frammento e con confronti con studi precedenti (Stanford per anni è stata la sala di regia del “padre” degli studi di genetica delle popolazioni, l’italiano Luigi Luca Cavalli-Sforza, scomparso nel 2018) i ricercatori sono riusciti a “disegnare” il profilo genetico degli antenati che fondarono Roma: un vero puzzle di etnie che va ad arricchirsi sempre più nei secoli successivi. Nella zona dove venne fondata la Città Eterna 8000 anni fa, erano stanziali, oltre a cacciatori-raccoglitori, agricoltori di origine mediorientale (anatolici e iraniani, o meglio, persiani). Successivamente, tra 5000 e 3000 anni fa, i campioni di Dna analizzati raccontano l’arrivo di popolazioni dalla steppa ucraina. Il miscuglio genetico aumenta con la fondazione di Roma e l’espandersi dell’Impero: il Dna “legge” la confluenza dai diversi territori, con una predominanza dalle aree mediterranee orientali e soprattutto dal Vicino Oriente. «Non ci aspettavamo di trovare una diversità genetica tanto ampia già al tempo delle origini di Roma, con individui con antenati provenienti dal Nord Africa, dal Vicino Oriente e dalle regioni del Mediterraneo europeo» sottolinea Ron Pinhasi, che insegna Antropologia evolutiva all’Università di Vienna, uno degli autori dello studio insieme a Jonathan Pritchard, professore di Genetica e Biologia all’Università di Stanford e a Alfredo Coppa, docente di Antropologia fisica alla Sapienza. Si può dire che tutte le strade portavano a Roma già prima che venisse fondata. E vista la presenza di Dna anatolici, iraniani e ucraini nel profilo genetico di Romolo-Remo & C., dopo questo studio continuare a pensare soltanto agli Etruschi, ai Sabini e ai cosiddetti Latini sembra riduttivo. «In effetti prima di questo studio si sapeva poco, o addirittura niente, di dati genomici sui romani – puntualizza Coppa -; tutti le ricerche sul Dna antico sono stato fatte su popolazioni preistoriche, al massimo protostoriche, nessuna su società classiche complesse come quella romana. Per questo il nostro studio ha avuto una risonanza così ampia».
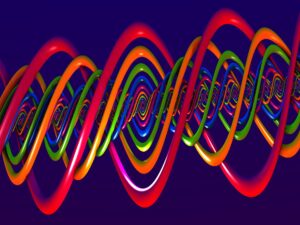
Dopo la fondazione dell’Urbe il quadro storico-archeologico rivela come la città-stato in una manciata di secoli conquistò il controllo di un Impero che si estendeva a nord fino alla Gran Bretagna, a sud nel Nord Africa e ad est nelle attuali Siria, Giordania e Iraq. L’espansione facilitò il movimento e l’interazione delle persone attraverso reti commerciali, strade, campagne militari e schiavi. La genetica conferma il quadro storico-archeologico. Pritchard sintetizza: «L’analisi del Dna ha rivelato che, mentre l’Impero Romano si espandeva nel Mar Mediterraneo, immigrati dal Vicino Oriente, dall’Europa e dal Nord Africa si stabilirono a Roma, cambiando sensibilmente il volto di una delle prime grandi città del mondo antico». E poi, che cosa accadde? L’albero genealogico si arricchì ancora nei secoli successivi segnati da eventi tumultuosi: il trasferimento della capitale a Costantinopoli, la scissione dell’Impero, le malattie che decimarono la popolazione di Roma, le invasioni, tra cui il saccheggio di Roma da parte dei Visigoti nel 410 d.C. Tutti eventi che non sono passati senza aver marchiato l’ascendenza della città, che si è spostata dal Mediterraneo orientale verso l’Europa occidentale.
Gli studi sul Dna antico modificano la nostra conoscenza della Storia, evidentemente. Ne è esempio un altro lavoro che ha confrontato il Dna mitocondriale (una parte del nostro patrimonio genetico è contenuto in corpuscoli, detti mitocondri, presenti nel citoplasma della cellula) dell’attuale popolazione toscana con quello estratto da ossa ritrovate in alcune necropoli. Ne è emerso che gli Etruschi non sono arrivati dall’Anatolia, come sosteneva Erodoto, ma erano una popolazione autoctona italica, ipotesi cara a Dionigi di Alicarnasso. Oggi i discendenti di quella antica popolazione sono pochi e dispersi in piccole comunità della Toscana. Per esempio, in un paesino non lontano da Siena, Murlo, una vera e propria “isola etrusca”, oggetto dei primi studi di genetica delle popolazioni condotti negli anni Sessanta da Luigi Luca Cavalli-Sforza.
In un momento storico in cui tornano fortemente di attualità i muri, è bene sottolineare che anche l’individuo più razzista porta in sé frammenti di Dna orientali e africani. Ricordo ciò che Cavalli-Sforza mi disse a Venezia nel 2006: «Gli unici muri che andrebbero innalzati sono quelli contro l’ignoranza».
Immagine di apertura: Arek Socha