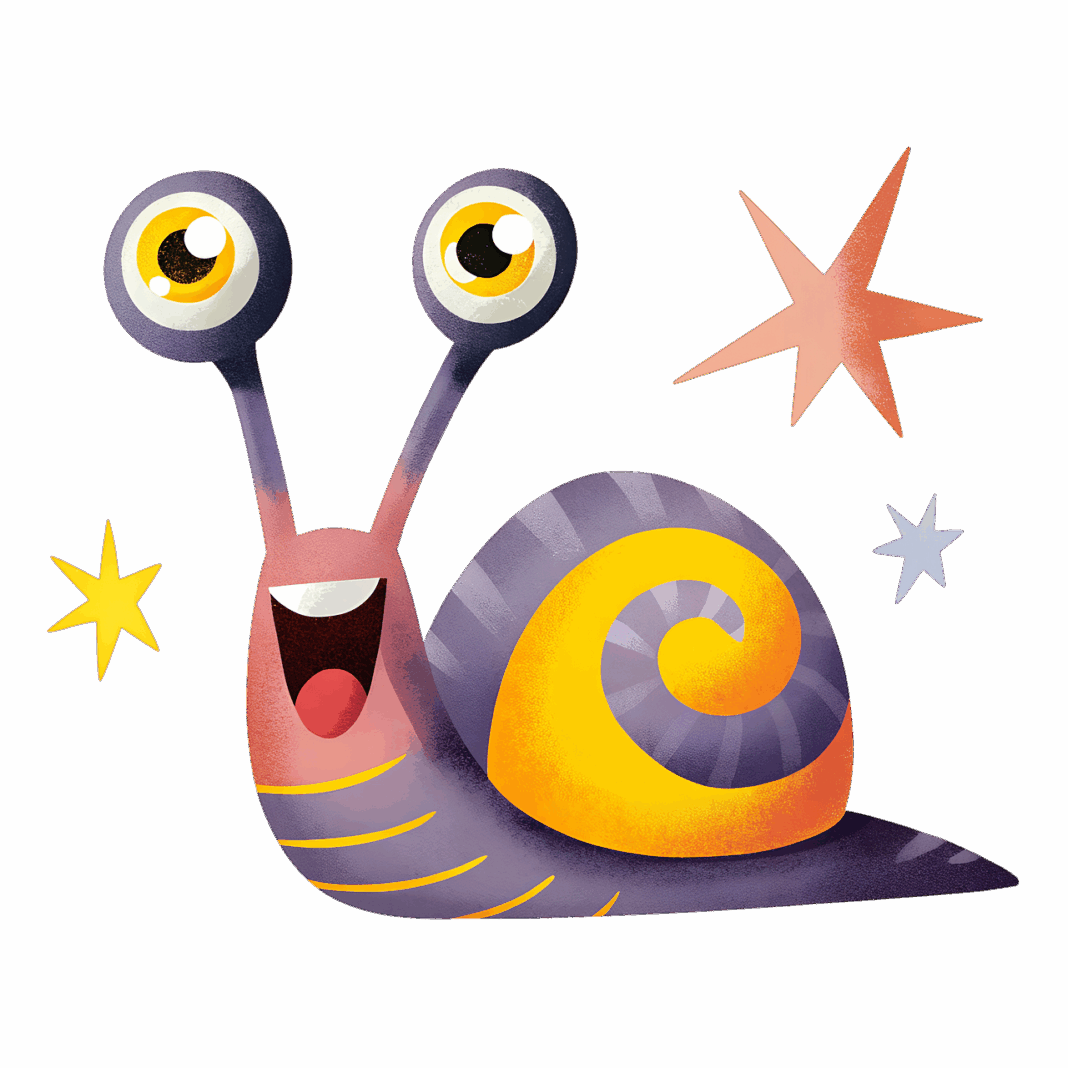Firenze 27 Giugno 2025
È noto che gli anziani subiscono spesso un rallentamento dei movimenti e dei ritmi di vita. Fare l’elogio della lentezza potrebbe sembrare un pietoso o ipocrita espediente per “santificare” quella che negli anziani non è una scelta ma una menomazione. Ma non è così: la scelta di vivere più lentamente è salutare anche per i giovani. La “lentezza nel vivere” significa avere la possibilità di assaporare la vita in quelle sfumature che sfuggono a chi vive di corsa. Riuscire a sottrarsi alla superficialità dei pensieri, dei sentimenti e delle interazioni umane inevitabilmente prodotta da una vita ad alta velocità. Basta pensare a quanto è devastante la fretta di consumare nella vita sessuale e, in generale, nell’erotismo. Il vivere lentamente è la precondizione necessaria per poter meditare sulle proprie esperienze, approfondirne il significato e il valore e accumulare un patrimonio di conoscenza di sé che può darci sostegno nella vita futura.

Bisogna ricordare, comunque, che la crescente velocità della vita degli ultimi due secoli non è stata una scelta per vivere meglio, bensì un ritmo imposto dallo sviluppo tecnologico, che ha plasmato l’esistenza dei popoli occidentali o “occidentalizzati”. In qualche modo, la velocità è stata subìta dai popoli vittime del progresso, salvo poi essere santificata da alcune correnti di pensiero, come il Futurismo, che, in verità, non ci hanno lasciato una apprezzabile eredità filosofica. Non a caso, molti Futuristi aderirono al Fascismo, il quale, a sua volta ne apprezzò l’esaltazione della velocità e dell’efficienza.
Ritrovare, anche in giovane età, il piacere di soffermarsi sulle cose e trasformarlo in uno stile di vita è la precondizione per potere, in vecchiaia, contare su di un più vasto patrimonio di pensieri e di esperienze che diano un senso alla nostra esistenza.

In un saggio ripubblicato recentemente dal Mulino, Elogio della lentezza, Lamberto Maffei, già Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si chiede se siamo davvero programmati per la velocità. Il mondo in cui viviamo ci impone ritmi sempre più rapidi, chiamati a rispondere ad ogni tipo di messaggi, bombardati da immagini che non riusciamo ad ignorare, impegnati in un lavoro di selezione che occupa ogni spazio della nostra mente.
Sono indiscutibili i vantaggi dei cellulari e dei computer che permettono di comunicare con i posti più remoti del mondo, di inviare o ricevere qualsiasi documentazione, effettuare operazioni bancarie senza spostarci dalla nostra scrivania. Entrare in contatto visivo in tempo reale, inviando la nostra immagine e ricevendo quella del nostro interlocutore in contemporanea da ogni parte del globo, non è più una sorpresa. Internet è la rete per eccellenza dove troviamo ogni tipo di informazione e ci dà la possibilità di accedere al mondo del sapere: dalle ricerche scientifiche più recenti alla storia degli umani.
Navigando in internet riusciamo a viaggiare nel tempo e nello spazio, guidati dai nostri interessi culturali, dalla curiosità, dal desiderio di conoscenza ma anche dalle nostre esigenze lavorative. Non abbiamo più confini, catturati da immagini sempre nuove che arrivano sul piccolo schermo del cellulare, che viaggia con noi in ogni momento del giorno. Oggi la rappresentazione antropologica di noi umani potrebbe essere quella dello smartphone che fa corpo unico coll’orecchio, come un tatuaggio!

Un cambiamento così radicale, non limitato alla comunicazione e alla acquisizione immediata di ogni tipo di dati, ha già rivoluzionato le nostre esistenze. Tuttavia le informazioni e le immagini che irrompono nella nostra mente con loro forza spesso seduttiva, possono ridurre lo spazio per la riflessione e per l’esercizio della capacità critica. Da qui la necessità di pensare in solitudine. Riuscire a stare soli è una conquista che richiede impegno ma ci dà la possibilità di sviluppare le nostre capacità creative e una comprensione più profonda della realtà che ci circonda.
La seduzione della velocità di connetterci prevale spesso sui tempi lunghi del discernere e della libertà di pensiero. Anche i rapporti sociali hanno sempre più spazio “in rete” con conseguenze non sempre positive: basti pensare alle difficoltà di comunicazione reale fra gli adolescenti, comunicazione spesso sostituita dallo smartphone.
Maffei racconta del suo vagabondare nei musei tra forme e colori che lo attraggono e aumentano la sua serotonina (sostanza prodotta dal nostro cervello e che ci mette di buono umore). Nel suo vagare lentamente nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio di Firenze, scorge nel soffitto immagini strane, tartarughe che hanno una vela gonfiata dal vento sul loro carapace e una scritta, Festina lente (affrettati lentamente).
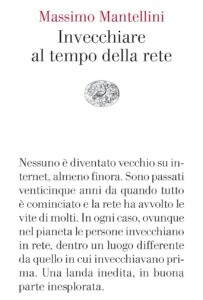
Sono affreschi di del grande pittore e architetto Giorgio Vasari fatti dipingere da Cosimo I de’ Medici come simbolo del suo modo di agire e del suo pensiero: pensa e rifletti prima di agire, poi corri nelle tue azioni. Ragionare richiede lentezza. Maffei ci ricorda che il cervello è lento e che il desiderio di emulare le macchine rapide da noi costruite crea angoscia e frustrazione. Ad una cultura che privilegia la rapidità della comunicazione visiva dovremmo affiancare il ritmo lento del linguaggio parlato e scritto. La realtà virtuale delle immagini, con il loro potere di catturare l’attenzione, non deve sostituire il contatto diretto con l’ambiente più ricco di stimolazioni sensoriali come l’udito, l’olfatto, il tatto. Anche la percezione di sé e dello spazio, la luminosità del giorno, il crepuscolo sono indispensabili per mantenere equilibrio e benessere. La natura ha i suoi ritmi, come il succedersi delle stagioni e del giorno alla notte, lo stesso vale per tutti i viventi. Sonno e veglia si alternano, così come attività e riposo. Dovremmo riconoscere, in un mondo in continua accelerazione, l’importanza della lentezza quale elemento fondamentale del benessere, della creatività, della crescita di noi umani e dell’ambiente in cui viviamo. Massimo Mantellini, uno dei maggiori esperti italiani della rete, in un recente saggio, Invecchiare al tempo della rete (Einaudi, 2023), osserva che nessuno, almeno finora, è diventato vecchio su internet, essendo trascorsi soltanto trent’anni anni da quando tutto è cominciato e la rete ha avvolto le vite dei molti. Ovunque le persone invecchiano in rete, luogo dominato dalla velocità del susseguirsi delle notizie e delle immagini, dove lo spazio per il pensiero e per la riflessione, come abbiamo visto, è sempre più ristretto. La lentezza ci salverà?
Immagine di apertura: foto di Tanrica