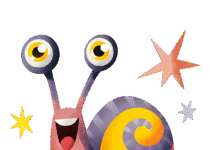Firenze 27 Gennaio 2022
L’armamentario del medico si basa sulla conoscenza delle malattie e delle strategie di indagine utili a rilevare i dati più importanti che lo portano alla diagnosi. Di fronte al paziente, chi indossa il camice bianco è come il ricercatore in laboratorio, impegnato a valorizzare ogni piccolo indizio utile alla propria scoperta. E il suo atteggiamento distaccato, concentrato sull’oggetto della propria indagine, non distratto dai fattori ambientali presenti, ricalca il rigore metodologico della ricerca scientifica, garanzia fondamentale per arrivare ad una corretta comprensione della realtà. Il termine “distaccato” si riferisce alla capacità del medico di estraniare dalle influenze ambientali, ma soprattutto di riconoscerne la presenza, evitando così di esserne influenzato nel percorso verso la diagnosi.

Tuttavia la realtà con cui viene in contatto il medico è molto più complessa del quadro che abbiamo appena descritto e tale da richiedere l’impiego di strategie apparentemente opposte al distacco. Distacco che è spesso espressione di un bisogno di distanza del camice bianco dalle emozioni che suscita in lui l’incontro con il paziente. In realtà la ricerca della razionalità e della obiettività non esclude, per poter veramente comprendere ed aiutare il malato, di disporre di una profonda empatia (“sentire con”, “mettersi nei panni di”) e di un coinvolgimento emotivo controllato che gli dia la possibilità di entrare nei vissuti della persona che ha di fronte. L’empatia può divenire così un ulteriore mezzo di indagine nella comprensione della malattia, assicurando al tempo stesso vicinanza e solidarietà al paziente in un momento di particolare vulnerabilità e insicurezza. L’empatia acquista, in sostanza, una funzione terapeutica.

Le strategie del rapporto medico-paziente sono state oggetto di studio nel secolo scorso da parte di numerose Scuole e indirizzi psicologici diversi, soprattutto di tipo psicodinamico o comportamentistico. Soprattutto dalla psicoanalisi e da Freud è venuta la maggior parte degli studi in questo ambito. È la sfera emotiva ad essere chiamata in causa, che coinvolge entrambi i soggetti del rapporto: curante e destinatario delle cure. La situazione impari della relazione, anche nella collocazione spaziale (il medico in piedi, il paziente in orizzontale sul lettino) favorisce una condizione di dipendenza dal medico vissuto come figura paterna e, comunque, protettiva. Una condizione regressiva che favorisce la disponibilità del malato al lasciarsi guidare. La componente emotiva nel rapporto coinvolge anche il medico con caratteristiche diverse, talvolta opposte. Dalla gratificazione per la stima e la fiducia che riceve dal proprio malato (sempre importante per mantenere alta la propria autostima professionale) si può passare al disagio fino al rifiuto del paziente invadente, manipolativo o aggressivo. È importante sottolineare che il vissuto emotivo del medico può diventare per lui uno strumento utile di conoscenza e di approfondimento dei problemi e delle reazioni del paziente alla malattia. Ne deriva che l’operatore sanitario dovrebbe esercitarsi ad una continua attività introspettiva verso le proprie reazioni emotive ed i vissuti in ogni momento del rapporto. In realtà il medico non è consapevole delle dinamiche interiori scatenate in lui dall’incontro con il paziente. A meno che non abbia fatto un lavoro su se stesso, quale un’esperienza psicoanalitica o abbia partecipato ai gruppi Balint (cosiddetti perché ideati dallo psicoanalista ungherese Michael Balint), un metodo consolidato di formazione degli operatori sanitari che ha lo scopo di aiutarli a comprendere gli elementi psicologici in gioco nella relazione di cura e a migliorarla.

Secondo questo metodo, il medico stesso è il farmaco principale che viene somministrato al paziente, e nel rapporto tra i due si possono produrre sofferenze ed irritazioni inutili, evitabili laddove il medico sia in grado di ascoltare e comprendere ogni paziente nella sua singolarità, entrando in relazione con lui consapevole del fatto che anche la loro relazione è parte sia dell’atto diagnostico sia dell’atto di cura. Sono state fondate associazioni nazionali, come l’Associazione Medica Italiana Gruppi Balint, raccolte entro una federazione, l’International Balint Federation. Purtroppo questo tipo di formazione non ha avuto ancora grande diffusione nel nostro Paese. Oggi viene attuata in casi limitati, mentre sarebbe indispensabile la sua diffusione per superare il dilemma tra le due posizioni, distacco ed empatia, in apparenza antitetiche, nel rapporto medico-paziente arrivando ad una sintesi. Ovvero l’inclusione e il controllo come consapevolezza anche di variabili soggettive relative sia al medico che al paziente.
Immagine di apertura: foto Pixabay