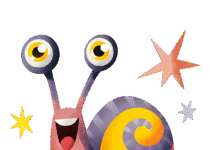Firenze 23 Febbraio 2021
Nel 1987 moriva in un ospedale di New York all’età di 69 anni Rita Hayworth. Nel 1980 le era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer. Il fatto che un’attrice così nota, per anni mito indiscusso di bellezza e fascino, ne fosse stata colpita e distrutta precocemente, scatenò una grande attenzione mediatica su una condizione patologica di cui allora si parlava pochissimo.

La malattia che porta il nome del neuropatologo tedesco che per primo la descrisse nel 1906, è caratterizzata da una rapida, o più o meno progressiva, perdita delle memoria, del linguaggio, delle capacità di giudizio e di orientamento nello spazio e nel tempo, fino alla compromissione delle più semplici attività quotidiane. La conseguenza è la totale dipendenza dagli altri, dall’aiuto ambientale senza che siano disponibili per ora terapie risolutive.
Purtroppo oggi L’Alzheimer ci è ben nota perché frequente (600.000 i casi in Italia) e per il peso che impone alle famiglie che si trovano ad assistere queste persone, spesso per lungo tempo. Assistenza non facile né semplice: il paziente vaga da una stanza all’altra nel tentativo di uscire di casa in preda all’agitazione opponendosi, spesso con aggressività, al famigliare o chiunque altro tenti di fermarlo e di proteggerlo. La comunicazione non verbale (quello dei gesti, della mimica, del tono e del volume della voce, della postura) viene mantenuta a lungo nel percorso della malattia; è pertanto quella che veicola meglio le emozioni in queste persone. Quindi, rassicurare il malato che vive in un ambiente che non capisce, in un mondo a lui diventato ostile e sconosciuto, è il primo atto terapeutico cui sono chiamati i famigliari con il supporto del medico di medicina generale, o medico di famiglia se preferiamo, la figura professionale più importante che viene a contatto con il paziente.
Prima di riflettere sulle modalità di relazione più “funzionali” ed efficaci per il medico di famiglia ma anche per qualsiasi altro specialista, è necessario tenere presente che nel malato di Alzheimer i deficit di memoria, di orientamento nello spazio e le difficoltà ad esprimersi si traducono in paura, smarrimento, ma anche in irrequietezza, agitazione, fino all’aggressività nei confronti di chi gli si avvicina. Come affrontare questa situazione? L’impiego di farmaci sedativi o tranquillanti è il mezzo più a portata di mano, ma gli effetti collaterali, anche a dosi contenute, rischiano di abbassare l’attenzione e di accentuare il deficit di memoria. Secondo noi, il farmaco più importante è, e rimane, il medico se riesce a comunicare al paziente disponibilità, accoglimento, protezione, senza mostrare fretta ed evitando di incalzarlo con il fuoco di fila delle domande necessarie per compilare l’anamnesi (la storia clinica del malato) che vuole registrare ogni piccolo e, forse, inutile dettaglio.

Spesso però è lo stesso medico a non essere sereno per una serie di motivi. Il primo è il pregiudizio (cui non si sottrae neppure chi indossa il camice bianco) nei riguardi della persona anziana che, in quanto tale, è per definizione uno smemorato e quindi avviato alla perdita di efficienza mentale. In realtà, è ampiamente dimostrato che la malattia di Alzheimer non è causata dall’invecchiamento anche se si verifica prevalentemente in tarda età. A confermarlo, l’alto numero di cosiddetti “grandi vecchi”, che mantengono un livello ottimale delle funzioni cognitive anche molto in là con gli anni. In sostanza, quando un anziano consulta il medico perché accusa una perdita di memoria, deve augurarsi di non incontrare chi è guidato, spesso senza rendersene conto, dall’idea, difficile da estirpare, della senectus ipsa morbus (la vecchiaia è già, di per sé, una malattia).
La strada giusta è quella di stabilire un rapporto di empatia con il malato di Alzheimer, un contatto che permetta una vicinanza più profonda. Purtroppo il paziente smemorato, al contrario, evoca nel medico angosce di morte, scatenando meccanismi di difesa che portano ad un rapporto frettoloso e superficiale. Allora il senso di impotenza che ne scaturisce lo spinge ad indulgere nell’uso di sedativi, evitando così quel trattamento compassionevole, quella vicinanza anche fisica che può servire da esempio e da suggerimento per i famigliari. Ricordiamo, però, che il medico per lo più non è consapevole di queste dinamiche interiori scatenate in lui dall’incontro con l’Alzheimer. A meno che non abbia fatto un lavoro su se stesso, quale un’esperienza psicoanalitica, o abbia partecipato ai Gruppi Balint (cosiddetti perché ideati da Michael Balint), un metodo consolidato di formazione degli operatori sanitari che ha lo scopo di aiutarli a comprendere in profondità la natura e le vicissitudini della relazione di cura e a migliorare la comunicazione con il paziente. Ma questa formazione riguarda, per ora, casi limitati.
Immagine di apertura: foto di Gerd Altmann
,
.
“.