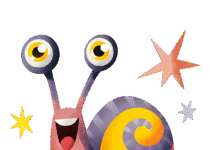Firenze 23 Giugno 2021
Le nostre concezioni sugli anni che scorrono stanno cambiando in virtù dei progressi scientifici. Non più invecchiamento quale processo in perdita, degenerativo, ma un continuo sviluppo che prosegue nell’età adulta e oltre. Ogni fase della vita offre nuove opportunità di integrazione delle esperienze e di crescita ben oltre l’età canonica del pensionamento e del disimpegno. Si vive di più e meglio, condizioni socioeconomiche permettendo, in una prospettiva di vita più ottimistica sostenuta da dati statistici inequivocabili.
Parallelamente all’espansione delle ricerche sull’invecchiamento c’è stato un aumento di interesse nei confronti delle persone anziane nelle nazioni più sviluppate. I nuovi studi, dalla genetica, alla fisiologia, alla sociologia, alla psicologia, alla antropologia, sostituiscono antichi stereotipi sulle persone anziane, esaminando le cause che nel corso della vita influenzano l’invecchiamento (James E. Birren, Encyclopedia of Gerontology, 2007).
Ma tale stato di cose ha cambiato a livello personale la percezione del nostro invecchiamento? In altre parole, se ci siamo lasciati cinquant’anni alle spalle o qualcuno di più, cominciamo a sentirci già vecchi? Stiamo parlando dell’invecchiamento soggettivo che, come è ovvio, non è uguale per tutti e non sempre dipende, anche se ne è influenzato, dal dato obiettivo dell’età cronologica. Come si può definirlo? Semplicemente è la consapevolezza della propria età, del tempo che abbiamo vissuto, di quello che ci dice lo specchio, delle prime rughe, dei capelli grigi. Ma è soprattutto il rapporto dinamico con l’ambiente e la sua cultura che contribuiscono alla percezione del nostro invecchiamento. Una improvvisa amnesia, un momento di stanchezza, ci viene restituito dall’ambiente come segnale di invecchiamento che inconsapevolmente interiorizziamo.

Il ruolo determinante dell’ambiente nel dar forma al nostro vissuto sull’invecchiamento lo vediamo nelle culture che privilegiano i giovani come forza lavoro e come modello che esprime il mito e il sogno dell’eterna giovinezza. In questi casi il rischio di chi va avanti negli anni è quello di vivere il proprio invecchiamento come un “perdente” nella nostalgia di un passato che non può più ripetersi. L’influenza della cultura e dell’ambiente è ancora più palpabile nei concetti relativamente rigidi ed eccessivamente semplificati o distorti, sugli anziani: fragili, smemorati, dipendenti dagli altri, non più affidabili, spesso depressi. Tali stereotipi, molto diffusi anche se non da tutti dichiaratamente condivisi, influenzano la nostra percezione dell’invecchiamento pur se siamo lontani dalla cosiddetta Terza Età. Sottintende a questo atteggiamento l’angoscia di morte che ci spinge verso il disimpegno e la depressione.
Da mettere in evidenza, inoltre, che il vissuto sul nostro invecchiamento, quando ormai da tempo ci siamo lasciati alle spalle la fase della maturità, è influenzato dal nostro stato di salute. Ci sentiamo vecchi quando qualsiasi malessere dura più a lungo rispetto alle nostre aspettative. Spesso sentiamo la vecchiaia come una malattia incurabile cui rassegnarsi. Attribuire all’età la causa di ogni male comporta il rischio della rassegnazione, e della mancanza di iniziativa che possa portarci alla guarigione. Oggi, alla luce della rivoluzionarie scoperte delle neuroscienze che dimostrano l’importanza, soprattutto in vecchiaia, dell’attività fisica e di ogni interesse culturale che costituisca uno stimolo per il cervello, ci rendiamo ancora di più conto dell’importanza degli aspetti soggettivi dell’invecchiamento. Sentire in positivo è vivere in positivo, vuol dire aumentare la propria aspettativa di vita. La gerontologa Suzanne Kunkel e l’epidemiologo Stanislav Kasl con una ricerca pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology nel 2002 dimostrarono come gli individui che hanno una percezione positiva dell’invecchiamento vivono in media 7,5 anni in più delle persone che ne hanno una percezione negativa.
Ricerche sulla età soggettiva condotte da numerosi studiosi (Barrett, Redmond e Rohr, 2012; Daatland, 2007; Diehl e Wahl, 2010; Rubin e Berntsen, 2006) hanno rivelato la discrepanza tra l’età cronologica degli anziani studiati e il loro modo di sentirsi, apparire e comportarsi.

Nella seconda metà della vita, sono numerosi gli individui che iniziano a dichiarare di sentirsi più giovani della loro età reale, in accordo con una citazione di Benjamin Franklin «ognuno vuole avere una vita lunga ma nessuno vuole invecchiare». Altro importante fattore che contribuisce alla percezione di quel sentirsi giovani anche da vecchi, viene dal nostro corpo. Un corpo tonico, non appesantito da un aumentata circonferenza addominale, non incurvato dal peso degli anni, non ci fa avvertire l’avanzare dell’età. In questo caso con molta difficoltà ci facciamo assimilare dal gruppo degli anziani in cui non ci riconosciamo. Genitori che si sentono giovani talvolta entrano i conflitto con i figli che si sentirebbero rassicurati da un rapporto di dipendenza dei loro anziani. Teniamo presente il detto “ognuno ha l’età che si sente”: è la frase iconica dell’invecchiamento soggettivo. A noi la scelta di sentirci più giovani dei nostri anni in controtendenza a difficoltà e ostacoli di percorso: riusciremo a vivere di più o, comunque, a vivere meglio.
Immagine di apertura: foto di Anna Shvets