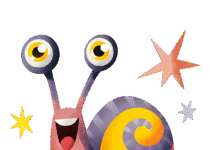Firenze 27 Febbraio 2025
Ai nostri giorni vivere più a lungo è un dato di realtà. Chi nasce oggi può prevedere di arrivare ad ottant’anni, a differenza dei soli cinquanta del 1900. Tuttavia per molti anziani questo aumento della aspettativa di vita si accompagna ad un indebolimento della memoria. Accade allora che venga evocata, o temuta, la malattia di Alzheimer, forse per esorcizzarla. «Non sarà mica l’Alzheimer?» è la domanda che viene rivolta al medico.

Agnese Codignola, giornalista scientifica di lungo corso, con una laurea in chimica e un dottorato in farmacologia, ha pubblicato di recente un libro ricco di informazioni e riferimenti bibliografici: ALZHEIMER S.P.A.” Storie di errori e omissioni dietro la cura che non c’è” (Bollati Boringhieri). Un libro che ha il merito di informare il vasto pubblico anche sui risvolti e sulle implicazioni economico-sociali dell’Alzheimer, delle ricerche e del giro di affari che ruota intorno alla malattia.
La scoperta del morbo di Alzheimer risale al 1906, quando Alois Alzheimer, psichiatra tedesco, descrisse il caso di una donna di cinquantuno anni, Auguste D., divenuta di colpo irrazionalmente gelosa del marito. Poco dopo, la donna sviluppò un deficit di memoria e una perdita progressiva delle capacità mentali. Non riusciva più ad orientarsi a casa sua, nascondeva gli oggetti, credeva che le persone volessero ucciderla. Ricoverata in clinica psichiatrica, morì cinque anni dopo. L’autopsia evidenziò una riduzione del volume del cervello, un materiale denso al di fuori delle cellule nervose (indicato ora come placche amiloidi) e, all’interno delle cellule stesse un accumulo di fibre proteiche aggrovigliate, chiamate grovigli neurofibrillari originati da una alterazione di un’altra proteina, chiamata Tau. Oggi si sa che placche amiloidi e grovigli neurofibrillari, che caratterizzano la malattia e concorrono probabilmente (ma non ci sono certezze) a causarla, si formano dieci o quindici anni prima della comparsa dei primi sintomi della malattia.

Fino a non molto tempo fa, tutti gli studi indicavano l’aggregazione amiloide come la causa fondamentale della demenza. Di conseguenza la ricerca si è concentrata sulla prevenzione della formazione degli aggregati e sulla rimozione di quelli preesistenti mediante il ricorso ad anticorpi che li riconoscano in modo specifico (anticorpi monoclonali). Uno di questi, aducanumab, prodotto da un’azienda americana insieme ad una giapponese, dopo anni di ricerca a Zurigo, ha ottenuto nel 2021 l’autorizzazione alla messa in commercio della Food and Drug Administration, l’ente regolatorio dei farmaci statunitense. Autorizzazione molto contestata per le deboli prove di efficacia e l’alto prezzo sul mercato: 56mila dollari annui, poi ridotti alla metà (la cura si fa con un’infusione mensile in ambito ospedaliero). Non a caso l’Agenzia che regola i farmaci in Europa, l’Emea, non ne ha autorizzato l’impiego nel Vecchio Continente. Nel 2023 un altro anticorpo monoclonale, lecanemab, ha ottenuto parere favorevole, suscitando anche in questo caso aspre critiche.
Nonostante la riduzione della beta-amiloide, non vi sono certezze sul miglioramento clinico garantito da questi preparati, mentre sono evidenti alcuni effetti collaterali quali, in alcuni casi, sia pur rari, edema ed emorragia cerebrale. Chiare riserve sull’impiego degli anticorpi monoclonali suggerirebbero di percorrere altre vie.

La storia degli insuccessi nella cura dell’Alzheimer inizia con i farmaci impiegati per potenziare le vie colinergiche, cioè la catena di neuroni che presiedono alle funzioni mentali, con risultati appena apprezzabili nelle forme indicate come sindrome amnesica benigna nell’anziano. In realtà per la la malattia di Alzheimer siamo ancora alla ricerca della pillola magica. Abbiamo scoperto il meccanismo che porta alla morte delle cellule cerebrali individuando nell’aumento dell’amiloide la responsabilità del danno, ma non abbiamo scoperto la causa di questo aumento. È forse quell’infiammazione lenta o di basso grado, tipica dell’invecchiamento, che ci accompagna per anni senza farsi sentire, con effetti deleteri sulla nostra salute, la causa della neurodegenerazione dell’Alzheimer? Mah, in realtà ancora oggi per una malattia che in Italia colpisce circa 600mila persone, non ci sono risposte. Fermarsi all’idea della beta-amiloide, la proteina tossica che invade il tessuto cerebrale, come si è fatto per molti anni, è probabilmente un’ipotesi semplicistica. Alzheimer S.p.A. racconta in che modo i colossi farmaceutici e ampi settori accademici abbiano per almeno vent’anni seguito una linea di ricerca sbagliata, spesso sapendolo, osteggiando lo sviluppo di indagini su ipotesi alternative e più promettenti.

Fra le centinaia di ricerche condotte negli ultimi anni – sottolinea Agnese Codignola – ve ne sono almeno una decina, svolte in in quasi tutti i continenti, che hanno portato a dati chiari. Ciò che emerge sempre – da analisi che hanno riguardato migliaia di persone nelle più diverse situazioni – è una evidente relazione tra la qualità dell’aria e le performance cognitive in età avanzata, così come con le patologie neurodegenerative in generale, e con Alzheimer, Parkinson, e Sclerosi Laterale Amiotrofica in particolare. Per esempio, secondo uno studio condotto in tutti gli Stati Uniti, e pubblicato sulla rivista PNAS nel 2022, nel quale i ricercatori della New York University hanno messo in relazione le concentrazioni di alcuni degli inquinanti principali (anche agricoli) con l’incidenza delle demenze, la sovrapposizione che ne risulta è impressionante, soprattutto per alcune sostanze e per le polveri più sottili, e quindi più insidiose, le PM2,5. È questa la linea di ricerca dove bisogna indirizzarsi?
Immagine di apertura: fonte: Hartmann Direct