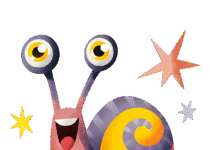Firenze 27 Marzo 2022
Si è in là con gli anni, quindi, “potenzialmente malati”. Un luogo comune vecchio di decenni che porta chi si trova sul crinale dei settant’anni ad intensificare le visite dal medico, gli esami del sangue, le Tac, le lastre e quant’altro. Come se tenersi aggiornati continuamente sul proprio livello di glicemia e di colesterolo, sullo stato di densità delle nostre ossa, sia indispensabile per essere costantemente rassicurati. Questo modo di ragionare avvalla il pregiudizio – molto diffuso anche fra i medici – che superata la sessantina, la salute diventi un bene a rischio. In realtà contrasta con i dati disponibili oggi sulla popolazione anziana in Italia, che risulta sostanzialmente sana. Inoltre i ritmi di decadimento sono oggi più lenti che in passato e, soprattutto, variano da individuo a individuo. Il dato più interessante in questo senso è che circa la metà degli anni da vivere dell’ultrasessantenne nel nostro Paese viene trascorsa in buona salute e l’80 per cento in assenza di disabilità.

Allora perché tutta questa enfasi sulla malattia? Fa parte del conformismo sulla terza età di cui abbiamo parlato più volte in questa rubrica e della “medicalizzazione” dell’esistenza tipica della nostra società di cui dobbiamo liberarci, tanto più da vecchi, perché limita la nostra libertà di vivere. Se la prevenzione primaria – una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura e povera di grassi, poco alcol, niente tabacco e tanto movimento – è fondamentale per stare bene, troppo spesso nelle campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione viene accompagnata da messaggi che enfatizzano i rischi di stili di vita scorretti. “Meglio prudenti che dispiaciuti”: questo slogan è nato per convincere all’adozione di pratiche salutari, ma ancora una volta è importante richiamare alla sobrietà della comunicazione in questi ambiti. “L’epidemiologia negativa” rischia di diffondere atteggiamenti pessimistici che alla fine ottengono l’effetto contrario, non portano l’individuo a modificare il proprio stile di vita, tutt’altro. Quando poi dalla prevenzione primaria si passa alla secondaria, quella che i medici chiamano diagnosi precoce, i problemi di comunicazione aumentano. Se è vero che aderire a una serie di screening collaudati, come quello mammografico, per il tumore del collo dell’utero e del colon-retto, è giustificato dai dati scientifici a loro favore, è altrettanto vero che i controlli devono avvenire in un clima di serenità e che il medico deve essere il mediatore che porge alla persona la risposta tecnica, corredandola delle spiegazioni necessarie a comprenderla, in un clima di empatia. Ma non sempre questo avviene anche perché chi indossa il camice bianco non è preparato a “comunicare”. Così molte persone escono da questi controlli senza aver capito niente, in preda a mille sospetti. In una persona anziana, poi, scattano ansie di ogni tipo. È, d’altra parte, sotto gli occhi di tutti che una delle voci che più incide sul bilancio di spesa è quella relativa agli esami del sangue e strumentali (ecografie, tomografie computerizzate dei vari organi, risonanze magnetiche), non sempre indispensabili. Qual è la causa di questo eccesso di richieste di esami? Un rapporto frettoloso da parte del medico che non dà molto spazio alla raccolta dei dati storici del disturbo e una visita altrettanto rapida che favorisce la richiesta di indagini strumentali, spesso costose.

Il paziente si sente così rassicurato dall’impegno del medico (“mi ha prescritto anche gli esami”!) che, da parte sua, si mette al sicuro da eventuali giudizi di superficialità o, peggio ancora, da conseguenze legali circa il proprio operato, qualora venga ritenuto responsabile delle conseguenze di una diagnosi non corretta. Un’ultima, doverosa, considerazione sui farmaci. È indubbio che negli ultimi decenni è andato crescendo un vero e proprio consumismo farmaceutico che non ha risparmiato gli anziani. La pillola è oggi una risorsa adatta a qualsiasi disagio, con automatismi che rasentano l’ingenuità: una per il dolore, una per la pressione, una per la tosse, una per l’insonnia, una per la stitichezza e così via, magari tutte insieme senza sapere che questi farmaci nel nostro organismo interagiscono tra di loro e vengono degradati più o meno negli stessi organi, fegato e reni. Un sovraccarico pericoloso soprattutto dopo i settant’anni, perché il metabolismo andando avanti con l’età rallenta.

Servono tutte queste medicine? Probabilmente no: si può provare a dormire con una tisana, si può curare la pressione alta (in certi casi) e i dolori articolari con l’attività fisica, si può evitare di far uso di lassativi privilegiando una dieta ricca di fibre. Ormai sono tante le evidenze scientifiche di questi benefici. Purtroppo i medici ancora oggi sembrano ignorare le ricerche in proposito e continuano, implacabili, a dispensare farmaci. Ne consegue che la vecchiaia – gli anziani sono un po’ come le donne prima dell’emancipazione – è costellata di rinunce, divieti, farmaci e ambulatori medici. Non deve meravigliare, perciò, che la spesa sanitaria in Italia per le patologie degli over 65 (reali e supposte), sia lievitata oltre misura, tanto che gli stessi addetti ai lavori la definiscono “incontrollata”.
È ora di cambiare passo. Non è un caso che di recente negli Stati Uniti, i National Institutes of Health, l’ente di finanziamento pubblico della ricerca, abbiano lanciato un programma per studiare l’invecchiamento sano, inaugurando un nuovo terreno di studi, la Geroscienza. Indubbiamente è il segnale di un mutamento.
Immagine di apertura: fonte cittadinanzattiva.it