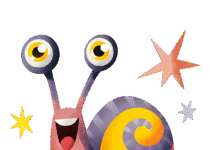Firenze 28 Aprile 2022
Nelle culture orientali la vita e la morte appartengono in pari misura al processo dell’esperienza umana e contribuiscono al significato stesso della persona (per il buddismo la morte è il momento della grande illuminazione). In Occidente la morte è considerata quasi un affronto, non certo quel passaggio necessario da una vecchia ad una nuova vita che indicano le nostre credenze religiose, il cammino verso un aldilà.

D’altro canto l’enfasi sul progresso e le conquiste sulla natura viste come elementi indispensabili alla realizzazione dell’uomo, hanno favorito l’emergere di un comune sentire che nega l’idea della morte. E la medicina tecnologica di questi ultimi decenni con i suoi potenti mezzi di rianimazione ha contribuito, e non poco, ad una sorta di illusione di immortalità. Ma, ricorda Umberto Veronesi, purtroppo scomparso, in I segreti di lunga vita (Giunti), scritto insieme al giornalista Mario Pappagallo: «Il fenomeno della cessazione della vita fa parte di un processo che riguarda tutti gli esseri viventi: uomini, animali, piante. La morte è per la scienza l’evento conclusivo del ciclo vitale e risponde al disegno biologico universale espresso nel Dna di ogni forma di vita. In questa visione la morte ha una funzione biologica: perché il ciclo della vita compia il suo rinnovamento continuo, è necessario lasciare spazio ai nuovi arrivati».
Facile a dirsi, più difficile da accettare, tanto più quando ci si avvicina al momento in cui il ciclo vitale sta per esaurirsi. Tra le sempre più numerose persone che oggi arrivano alla vecchiaia, c’è qualcuno che guarda alla morte in modo consapevole anche senza verbalizzarne il pensiero, con soddisfazione verso le conquiste del passato e con un senso di appagamento per la vita vissuta. Ma certo non è il comune sentire. Eppure, la minore energia che ci ritroviamo con il passare degli anni può facilitare un’attitudine alla riflessione. Altro elemento importante nel processo di adattamento al fine vita è un rapporto non ambivalente con i figli e i nipoti, tale da soddisfare bisogni affettivi reciproci. Ma soprattutto dare all’anziano il senso della continuità della vita, evidenza tangibile del proprio contributo al genere umano. Anche il decidere su quello che lasciamo ai figli o agli amici è un segno importante dell’accettazione di una vita che si chiude.

Sotto l’aspetto clinico il momento terminale può presentare aspetti di drammaticità: è come se la malattia che ci porterà alla fine ci trovasse impreparati, soprattutto se siamo vissuti fino a quel punto in una nostra bolla di immortalità. Un importante contributo al concetto dell’adattamento verso la morte, quale processo temporale, è stato quello della psichiatra svizzera Elizabeth Kübler-Ross (1926-2004) con il libro La morte e il morire, pubblicato per la prima volta a Londra nel 1969, da noi da Cittadella editrice nel 2013, dove ha raccolto un grande numero di interviste con i pazienti terminali e il personale assistente, dati che ha poi concettualizzato come tappe o stadi successivi. In un primo stadio il paziente di fronte alla malattia, che segnerà in breve tempo la sua fine, dopo lo shock iniziale, tende a dubitare della diagnosi fino a ritenerla errata. Si tratta di un meccanismo inconscio di negazione, che permette al soggetto di prendere la distanza da una realtà improvvisa e drammatica che non riuscirebbe a reggere. L’incredulità lo fa apparire estraneo e non coinvolto dalla gravità della situazione, come se la prognosi infausta riguardasse un altro/a. Anche la richiesta di ulteriori esami o di pareri medici diversi è una modalità che sottintende un meccanismo di negazione. Segue un secondo stadio dominato dalla rabbia spesso diretta verso le persone più prossime, famigliari o personale sanitario, responsabili di non averlo curato in tempo. Lo stadio successivo è quello del mercanteggiare o di patteggiare, promettendo di comportarsi secondo quanto viene prescritto per ottenere un prolungamento della vita. Formulando propositi di generosità verso il prossimo, affidandosi e invocando l’aiuto divino. L’impatto della malattia favorisce in seguito la tristezza e la disperazione, configurando così un momento depressivo. L’ultimo stadio è caratterizzato dall’accettazione della malattia.
Le tecnologie mediche più avanzate hanno fornito al giorno d’oggi una serie di misure per migliorare l’assistenza al malato terminale, ma tutto questo non basta.

È emerso sempre di più il bisogno di un rapporto umanistico in questa fase dell’assistenza perché molto spesso la vicinanza fra il medico e il paziente viene a mancare in un momento, in cui l’ascolto, la parola, lo sguardo, il contatto anche fisico come un mano che stringe quella di chi è arrivato al traguardo dell’esistenza, sono fondamentali e non sostituibili da alcun presidio tecnologico. Il paziente viene talvolta indicato con il numero del letto che occupa in ospedale o con la diagnosi (“l’ictus della stanza 2”) togliendogli ogni identità, disumanizzandolo, allontanando da noi medici quell’angoscia di morte che toccherà poi anche a noi.
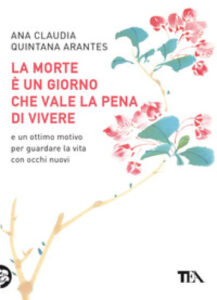
La morte, ancora così negata (un vero tabù) nella società attuale tanto che si riesce ad affrontarla soltanto in una cornice scientifica, ha trovato, nella esperienza di Ana Claudia Quintana Arantes, geriatra e gerontologa dell’Università di San Paolo in Brasile, specializzata presso l’Università di Oxford nell’ambito delle cure palliative, impegno e dedizione totale, partecipazione emotiva senza riserve al paziente terminale, alle sue paure e alle angosce di “vivere la morte”. L’esperienza intensa della Quintana Arantes, anche con sofferenze fisiche e psicologiche, momenti di sconforto e dubbio sulla scelta professionale che ne hanno segnato profondamente l’esistenza, è riportata nel suo libro appena uscito in Italia per Tea edizioni, La morte è un giorno che vale la pena di vivere. Un libro che sta riscuotendo un grande successo – in America Latina è un vero best seller – e che non può non suscitare, soprattutto nei medici, un senso di gratitudine verso una collega che ha aperto uno spiraglio, forse una porta, verso chi sta vivendo gli ultimi momenti della sua esistenza terrena.
Immagine di apertura: foto Pixabay