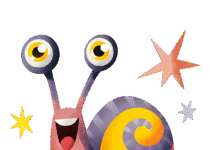Firenze 27 Settembre 2022
L’errore nell’esercizio della professione medica, come in ogni altra attività umana, è sempre possibile. Tanto che si dice che il medico bravo sia quello che sbaglia meno degli altri. L’errore è quasi una componente fisiologica, come sottolinea l’errare humanum est di proverbiale memoria. Ma il solo pensare che il medico possa sbagliare nel momento in cui ci affidiamo alle sue cure aumenta in noi l’insicurezza fino allo smarrimento di fronte alla malattia, proprio quando abbiamo bisogno di certezze. Inconsapevolmente vogliamo il medico come figura onnipotente che non può sbagliare. Ma le statistiche sugli errori dei medici ci riportano alla realtà. Errori dei medici e del personale sanitario che possono dare luogo a conseguenze talvolta irreversibili e gravi, fino alla morte del paziente.

In Italia gli errori più frequenti che si verificano in ambiente ospedaliero, vengono segnalati in ambito chirurgico e raggiungono il 38,4 per cento, causati da imperizia operatoria. Altrettanto importanti sono gli errori diagnostici che toccano la cifra del 20,7 per cento dei casi, quelli terapeutici (10,8) e le infezioni in ospedale o al pronto soccorso (6,7)
Questi dati forniti dallo “Sportello Legale Sanità”, di Roma, Milano e Bologna, hanno un valore solo indicativo. Non abbiamo, fino ad oggi, dati certi sugli errori del medico, tanto meno nella sua attività di libero professionista. Negli Stati Uniti, dove le compagnie assicuratrici contribuiscono ad individuare gli errori diagnostici a scopo di risarcimento, i casi di decesso da “Malasanità”, sono compresi tra i 40.000 e gli 80.000 all’anno.
I dati statistici, indispensabili ai fini della ricerca, sono sempre eloquenti per una percezione immediata del problema. Ma al di là del linguaggio dei numeri e delle percentuali sulla organizzazione sanitaria, pubblica o privata, numero di posti letto, di personale sanitario e di attrezzature tecnologiche disponibili, è sempre il medico la figura professionale centrale su cui grava il compito della sintesi diagnostica e di ogni decisione terapeutica, quindi la responsabilità dell’errore.

Quali sono le cause più importanti dell’errore attribuibile al medico, o meglio gli elementi che riducono al minimo il rischio di sbagliare? Una preparazione universitaria adeguata al primo posto, che permetta al medico di riconoscere nel paziente segni e sintomi caratteristici della malattia che ha imparato a conoscere dai testi e poi, durante il tirocinio, al letto del malato. Elemento fondamentale e premessa indispensabile per ridurre gli errori è seguire correttamente le varie tappe di indagine, sui disturbi presenti e remoti che potrebbero avere rapporto con lo stato attuale. Ascoltare e osservare valorizzando sia gli aspetti soggettivi (quello che il paziente ci riferisce) sia il rilievo oggettivo di eventuali segni quali valori pressori elevati, pallore, fegato aumentato di volume alla palpazione e così via.
L’errore in medicina è tanto più frequente quanto meno venga rispettato un corretto modo di procedere nella nostra indagine al letto del malato, per cui potremmo affermare che l’errore stesso, all’origine, è sempre un errore metodologico.

La formazione del medico, iniziata nelle aule universitarie deve proseguire lungo tutto il percorso professionale, nelle corsie ospedaliere o negli studi privati, dove l’apprendimento è anche continuo aggiornamento su riviste mediche di prestigio (per esempio, l’inglese The Lancet, o l’americana New England Journal of Medicine) in realtà poco frequentate dai nostri camici bianchi, perfino da quelli universitari. Una regola non detta, per ridurre il rischio dell’errore diagnostico, e quella del dubbio metodico, di memoria cartesiana: se questa è la diagnosi più probabile, quale l’alternativa diagnostica più vicina?
È sempre necessario mantenere agilità mentale che permetta la medico di seguire la malattia, realtà spesso in continuo cambiamento. La fretta verso la diagnosi può soddisfare il medico sottraendolo all’angoscia dell’incertezza, ma può favorire l’errore.
Ascoltare il paziente è il momento fondamentale che ci permette di raccogliere ogni piccolo dettaglio spesso indispensabile ad una diagnosi corretta. Oggi le persone trascorrono molto tempo su Internet e talvolta pensano di saperne più del medico ponendosi con lui in un rapporto dialettico, nella convinzione o, talvolta, con la pretesa di suggerire la diagnosi. In realtà, il paziente “erudito”, più che un intralcio, può rappresentare una condizione favorevole alla comunicazione, comunque utile al percorso diagnostico. Gli atteggiamenti dogmatici del medico che si sente spodestato del proprio ruolo, comportano il rischio di una contrapposizione col malato che favorisce l’errore.
La medicina, pur avendo una solida base scientifica viene definita anche un’arte soprattutto negli aspetti relazionali tra medico e paziente che comportano fattori quali empatia e capacità di ascolto, dove il linguaggio non verbale del medico comunica più efficacemente disponibilità, protezione, vicinanza. Tenendo presente tali condizioni, l’errore del medico, favorito dalla fretta e dalla lontananza emotiva è meno probabile.
Immagine di apertura: fonte: Risarcimento DANNI.INFO
.